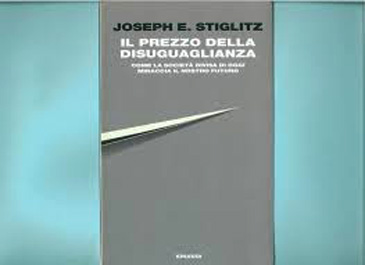La disuguaglianza non è inevitabile, Joseph E. Stiglitz
Questo scritto del premio Nobel per l’Economia Joseph Stiglitz è veramente straordinario, nel senso che non capita tutti i giorni di sentire da una persona che è stata consigliere economico di Clinton (anni 1995-1997), vicepresidente e capo-economista della Banca Mondiale (1997-2000) e premio Nobel per l’economia (nel 2001, assieme a George Akerlof e Michael Spence), giudizi tanto sinceri quanto espliciti e duri sul sistema politico-economico americano. Con chiarezza, coraggio e soprattutto passione per la democrazia, Stiglitz punta l’indice accusatorio contro la diffusa opinione che la Grande Recessione, cioè la crisi economica che stiamo vivendo, sia il prezzo inevitabile da pagare per godere dei benefici di un sistema economico che si è dimostrato il migliore tra quelli possibili. Abbiamo scelto quest’articolo come quello più adatto per chiudere l’argomento del mese - Quantoè importante la disuguaglianza? - con l’affermazione che la disuguaglianza è davvero un aspetto estremamente importante della vita del sistema economico-politico dell’intero mondo occidentale, e quindi anche di quello italiano. Ma anche con la consapevolezza che è un aspetto che dipende da noi, e dalle nostre scelte politiche, e non ci è imposto da un qualche malevolo ente (Dio, la natura, o quello che volete voi) che sta al di fuori noi e contro il quale non possiamo fare niente.
Presento questo articolo di Stiglitz anche come mio primo contributo al nuovo argomento del mese - Dov’è la buona notizia? - perché una prima risposta alla domanda è anche, come sempre, spiegare i motivi che giustificano la sua formulazione. Gesù ha annunciato la buona notizia a un mondo in crisi profonda, per molti versi paragonabile all’attuale, ma era una buona notizia solo per i più poveri, gli esclusi, i diseredati, per coloro che, come dice Papa Francesco, sono lo scarto della società. Per gli altri, per la crema della società di allora, la buona notizia di Gesù era, nel migliore dei casi, una seccatura. E infatti non l’hanno accolta e hanno lasciato che la “legge” avesse il suo corso e Gesù fosse messo a morte. Chiedersi ora, a duemila anni di distanza, dove sia la buona notizia ha senso solo se ciò che ci interessa continua ad essere la sorte dei più poveri. Esattamente come preoccuparsi per la crescita della disuguaglianza ha senso solo se si sta dalla parte di coloro che di questa crescita sono le vittime.
Buona lettura!
Gianni Mula
Negli ultimi decenni si è sviluppata in questo paese una tendenza pericolosa. Per più di trent’anni dopo la seconda guerra mondiale abbiamo avuto una crescita di cui beneficiavano tutti gli strati sociali. Poi [con l’era Thatcher-Reagan. NdT] i benefici hanno cominciato a non essere più di tutti. E dalla fine del 2007, cioè dallo scoppio della Grande Recessione, l’ingiustizia del sistema economico americano è diventata tanto evidente da non poter più essere ignorata. Come ha fatto questa nostra “città splendente sulla collina” [il riferimento è al sogno puritano di una nazione giusta e pia sotto Dio. NdT] a diventare il paese avanzato con il massimo livello di disuguaglianza?
Un ramo della discussione straordinariamente ampia messa in moto dall’uscita del tempestivo e importante libro di Thomas Piketty, “Il Capitale nel XXI secolo“, è imperniato attorno all’idea che questi estremi di ricchezza e di reddito siano una stretta conseguenza del sistema capitalistico. Da questo punto di vista dovremmo considerare i decenni dopo la seconda guerra mondiale – un periodo di disuguaglianza in rapida diminuzione – come un’aberrazione del sistema.
In realtà questa è una lettura superficiale dell’opera di Piketty, che è principalmente rivolta a spiegare perché la disuguaglianza aumenta nel tempo. Purtroppo questa parte della sua analisi ha ricevuto meno attenzione di quella dedicata all’inevitabilità della disuguaglianza come conseguenza delle leggi fondamentali del capitalismo.
Ma oggi la stessa idea che ci siano leggi fondamentali del capitalismo è in discussione, come è stato dimostrato da una vasta gamma di interventi a The Great Divide (La grande divisione), il dibattito che il New York Times ha ospitato per l’ultimo anno e mezzo e di cui ero moderatore. La dinamica del capitalismo imperiale del XIX secolo non può essere la stessa delle democrazie del XXI secolo. Non abbiamo bisogno di così tanta disuguaglianza in America.
Inoltre il capitalismo attuale è una sorta di surrogato di quello vero. Intendo dire che la nostra risposta alla Grande Recessione è stata quella di socializzare le perdite e privatizzare i profitti. Ma in un regime di concorrenza perfetta i profitti dovrebbero tendere a zero, almeno teoricamente. Invece abbiamo monopoli e oligopoli che fanno persistentemente elevati profitti e i loro amministratori delegati godono di redditi in media 295 volte maggiori di quelli di un lavoratore normale. Si tratta di un rapporto molto più elevato che in passato, e senza alcuna proporzione con l’aumento della loro produttività.
E allora, se non sono le leggi inesorabili dell’economia che hanno portato alla grande divisione americana [tra l’1% più ricco e il resto della popolazione. NdT], che cosa è stato a produrla? La risposta è semplice: la nostra politica. La gente è stanca di sentir parlare di storie di successo economico dei paesi scandinavi, quando il nocciolo della questione è capire come fanno questi paesi a far crescere il proprio reddito pro capite quanto o meglio degli Stati Uniti pur mantenendo un livello di uguaglianza di gran lunga maggiore.
Perché l’America ha scelto politiche che favoriscono l’aumento della disuguaglianza? Parte della risposta è che assieme alla Seconda Guerra Mondiale abbiamo dimenticato anche la solidarietà che allora ci univa. L’America ha vinto la guerra fredda perché il suo modello economico si è rivelato superiore agli altri. Cessata questa competizione internazionale, non abbiamo più avuto la necessità di dimostrare che per la maggior parte dei nostri concittadini il nostro sistema economico manteneva davvero ciò che prometteva.
Ideologia e interessi si sono combinati per produrre un risultato nefasto. Qualcuno ha tratto la lezione sbagliata dal crollo del sistema sovietico. Lì c’era stato un’intervento eccessivo del governo nell’economia, qui c’è n’è troppo poco. Ma sono state le multinazionali a spingere per sbarazzarsi di ogni regola, anche quando le regole si erano rivelate essenziali per tutelare e migliorare il nostro ambiente, la nostra sicurezza, la nostra salute e la stessa economia.
Che si trattasse di una scelta ideologica ipocrita lo si è capito quando i banchieri, da sempre tra i più accesi sostenitori del liberismo economico e contrari a ogni intervento dello stato nell’economia, si sono mostrati fin troppo disposti ad accettare centinaia di miliardi di dollari da parte del governo. I salvataggi bancari sono diventati una caratteristica ricorrente dell’economia globale sin dall’inizio dell’era Thatcher-Reagan di mercati “liberi” e di deregolamentazione.
Il fatto è che il sistema politico americano annega nel denaro, la disuguaglianza economica si traduce in disuguaglianza politica, e la disuguaglianza politica produce una crescente disuguaglianza economica. Come riconosce anche lo stesso Piketty questa crescita indefinita della disuguaglianza deriva dalla possibilità per i possessori di ricchezza di godere per i propri capitali di un tasso di rendimento, al netto delle imposte, superiore al tasso di crescita dell’economia. Come può accadere questo? Attraverso la politica, che, decidendo le regole del gioco, ha sinora prodotto questo risultato.
Ma com’è che mentre aumenta il benessere delle aziende diminuisce quello dei poveri? Perché il parlamento sovvenziona gli agricoltori ricchi ma continua a tagliare i programmi di assistenza alimentare per coloro che non hanno da mangiare a sufficienza. Oppure perché si regalano centinaia di miliardi di dollari alle compagnie farmaceutiche e contemporaneamente si limitano le risorse a disposizione di Medicaid [programma di assistenza medica per i più bisognosi. NdT]. Le banche che hanno portato all’attuale crisi hanno ricevuto dallo Stato miliardi, mentre a coloro che hanno perso la casa e alle altre vittime delle pratiche predatorie delle stesse banche è andata una miseria. Quest’ultima decisione è stata particolarmente stupida perché c’erano alternative alla scelta di regalare i soldi alle banche e limitarsi a sperare che il denaro sarebbe entrato nel circuito economico attraverso l’incremento nel numero dei prestiti. Ad esempio avremmo potuto aiutare direttamente i proprietari di casa in difficoltà e le altre vittime. Questo non solo avrebbe aiutato l’economia, ma avrebbe avviato una nuova fase di crescita.
Le divisioni che ci separano sono profonde. La separazione economica e geografica ha reso chi sta al vertice incapace di percepire i problemi di quelli che stanno alla base. Come i re di una volta, quelli al vertice considerano un diritto naturale le posizioni di privilegio di cui godono. Impossibile spiegare altrimenti le recenti osservazioni del grande finanziere Tom Perkins, che ha affermato che criticare i privilegi dell’1% era un comportamento da nazisti, o quelle di Stephen A. Schwarzman, quell’altro titano della finanza che ha paragonato all’invasione della Polonia da parte di Hitler la richiesta di tassare i redditi da capitale allo stesso modo dei redditi da lavoro.
Sono state la nostra economia, la nostra democrazia e la nostra società a pagare il prezzo di queste ingiustizie. Il banco di prova di un’economia non è la ricchezza accumulata nei paradisi fiscali, ma il benessere del cittadino medio – tanto più in America, nella cui auto-immagine è radicata la pretesa di essere la società della grande classe media. Ma i redditi medi sono oggi più bassi di un quarto di secolo fa perché l’aumento del reddito è andato prevalentemente a coloro che già stavano molto, molto in alto, e che oggi si dividono una percentuale del reddito totale quasi quattro volte maggiore di quella del 1980. I soldi che sarebbero dovuti percolare verso il basso sembrano invece essere evaporati al tepore del sole delle isole Cayman.
Con quasi un quarto dei bambini americani di età inferiore a 5 anni che vive in povertà, e con l’America che fa così poco per i suoi poveri, le privazioni di una generazione vengono trasmesse alla generazione seguente. Certo, è vero che mai nessun paese è riuscito a realizzare una completa uguaglianza di opportunità, ma perché l’America è, tra i paesi avanzati, quello dove le prospettive di vita dei giovani sono più fortemente dipendenti dal reddito e dall’istruzione dei genitori?
Tra le storie più toccanti raccontate e discusse in The Great Divideci sono quelle delle frustrazioni dei giovani che vorrebbero entrare a far parte di una classe media che continua a restringersi. L’aumento delle tasse universitarie e il calo dei redditi hanno portato a un grande aumento del peso del debito [nei bilanci delle nuove famiglie. NdT]. Quelli con solo un diploma di scuola superiore hanno visto i loro redditi diminuire del 13% negli ultimi 35 anni.
Anche dove sono in gioco questioni fondamentali di giustizia c’è un divario che continua ad aumentare, al punto che, agli occhi del resto del mondo e di una parte significativa della propria popolazione, l’America è diventato il paese che si segnala per la sua politica di incarcerazione di massa – siamo un paese, vale la pena ripeterlo, che col 5% della popolazione mondiale ha circa il 25% dei detenuti di tutto il mondo.
Il fatto è che la giustizia è diventata una merce che solo pochi si possono permettere. Infatti i dirigenti di Wall Street hanno potuto usare avvocati di alto prestigio (e di alto costo) per garantirsi l’impunità per i crimini che la crisi nel 2008 ha poi così drammaticamente evidenziato, e le banche hanno usato e abusato del nostro sistema giuridico per impedire la rinegoziazione dei mutui e per sfrattare le persone, talvolta anche quelle senza altri debiti.
Più di mezzo secolo fa è stata l’America a fare da battistrada per la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, poi approvata dalle Nazioni Unite nel 1948. Oggi che l’accesso alle cure sanitarie è fra i diritti più universalmente accettati, almeno nei paesi avanzati, l’America, nonostante il varo dell’Affordable Care Act, altrimenti noto come Obamacare, è l’eccezione negativa. Siamo diventati un paese con grandi disuguaglianze nell’accesso alle cure sanitarie, nell’aspettativa di vita e di stato di salute.
Nel sollievo che molti hanno espresso quando la Corte Suprema non ha approvato la richiesta di giudicare incostituzionale l’Affordable Care Act, le implicazioni di quella decisione per la diffusione di Medicaid non sono state pienamente valutate. Perché in pratica quelle motivazioni permettono agli Stati di rifiutare i finanziamenti federali necessari per il raggiungimento completo dell’obiettivo di Obamacare – che tutti gli americani abbiano accesso alle cure sanitarie – e quindi di fatto lo ostacolano: sono 24 gli Stati che hanno deciso di non attuare il programma Medicaid espanso, che era il mezzo con cui Obamacare avrebbe dovuto garantire l’assistenza sanitaria ai più poveri.
Non abbiamo bisogno solo di una nuova guerra alla povertà, ma anche di una guerra per proteggere la classe media. Le soluzioni a questi problemi non sono strane diavolerie. Anzi, sarebbe già un buon inizio far funzionare i mercati come mercati. Dobbiamo porre fine a una società che favorisce le rendite e nella quale i più ricchi guadagnano dal manipolare per i propri fini il sistema economico.
Il problema della disuguaglianza non è una questione di corrette tecniche economiche ma di concrete scelte politiche. Far pagare a quelli che stanno in alto la loro giusta quota di tasse – cioè porre fine ai privilegi di speculatori, multinazionali e megaricchi – è sia fattibile che giusto. Far cambiare di segno una politica sinora a favore dei più avidi non significa avviare una politica basata sull’invidia. La disuguaglianza non riguarda solo l’aliquota fiscale per lo scaglione più alto, ma anche l’accesso dei nostri figli al cibo e il diritto alla giustizia per tutti. Decidendo di spendere di più per l’istruzione, la sanità e le infrastrutture, rafforziamo la nostra economia, ora e in futuro. Aver già sentito inutilmente questo ritornello non significa che dovremmo smettere di provarci.
Abbiamo individuato l’origine del problema: la crescente disuguaglianza ha determinato la mercificazione della politica e corrotto la nostra democrazia. Solo come cittadini impegnati siamo davvero in grado di lottare per un’America più giusta, e possiamo farlo solo se comprendiamo in profondità le dimensioni della sfida. Non è troppo tardi per riguadagnare il rispetto del mondo e ritrovare il senso di chi siamo come nazione. L’aumento e l’aggravamento della disuguaglianza non dipendono da immutabili leggi economiche, ma sono il risultato di leggi scritte da noi stessi.
(Traduzione di Gianni Mula)