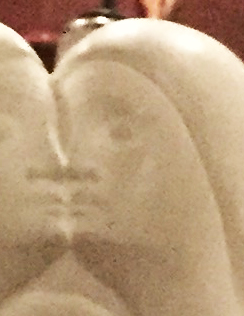«O Francesco, o Fratello!». S’avvicinano per Ciusa le doverose ricordanze nel 70° della scomparsa,di Gianfranco Murtas
Nel 1986 a Cagliari fu fondata da un pugno di liberi muratori amanti l’arte e la storia, fra i quali era – e se ne mostrava assai gratificato, galantuomo di parola – Fabio Maria Crivelli, direttore per lunghi anni de L’Unione Sarda, una loggia all’obbedienza del Grande Oriente d’Italia. Essa fu intitolata a Francesco Ciusa, che aveva maturato la sua esperienza massonica fra Oristano e Cagliari pochi anni prima che sul continente europeo scoppiasse la grande guerra.
Quel certo giorno l’Oratore, titolare di una delle dignità principali della più tipica compagine massonica, donò ai suoi un piccolo gruppo scultoreo – quaranta centimetri di altezza su un piedistallo rettangolare di cm. 27x15x6 – delicato tanto nell’intenzione quanto nella fattura: accostati fra loro in dolce intimità i volti ed i corpi dell’uomo e della donna, una mano di ciascuno/a protesa al plesso solare dell’altro/a, e nel mezzo, come germinati da un amore tenero, il viso d’una creatura e le sue braccine conserte. Titolo dell’opera: “la Vita”.
Ad ogni tornata rituale – trascorsa poi, dopo un incipit affidato ai versi di Quasimodo o Montale o ad un didascalico breve racconto di Salvatore Cambosu, a discutere dei lampi di sapienza di Ermete Trismegisto e Teofrasto Paracelso o del rapporto medico-malato, dell’educazione scolastica e dello spirito sportivo nella stessa pratica agonistica, della simbologia templare e della biografia profetica di Giuseppe Mazzini – quell’opera in gesso bianco viene (ancora oggi) suggestivamente collocata accanto alla menorah ebraica, alla Bibbia giovannea e alla squadra combinata al compasso: l’idea di Sardegna e l’idea dell’arte come linguaggio universale sono associate agli strumenti canonici dell’ars regia.
Mi sembra sia stata una intuizione corretta e infinitamente gustosa, carica di significati quella di chiamare insieme proprio tanta Sardegna e tanta universalità a sposare il programma della Libera Muratoria nell’ordinario concreto del pensare e del fare attraversando le rigide incombenze delle professioni e lo stretto dettato dell’agenda quotidiana dei partecipanti.
In tempi di trombe leghiste e monatti pentastellati, dopo l’uragano demagogico e immorale di Berlusconi e dei suoi fedeli pagani (piduisti o meno), dopo tante imbecilli declamazioni di qualche egotista che doveva risollevare la patria dalla melma del cattivo governo, mi è venuto di pensare a queste scene nate lontane nel tempo, discrete e perbene, ma tuttora celebrate nel cuore di Cagliari con l’ansia di rinvigorire l’interessamento sociale e, per quanto sia nella potestà delle coscienze critiche convocate all’impegno civico, la tolleranza dell’ascolto e l’operante democrazia repubblicana.
Il mio Archivio storico generale della Massoneria sarda ha acquisito, ora cospicui ora deboli, i faldoni della storia di pressoché tutte le logge isolane, dal 1861 ad oggi, e nel contesto anche le carte documentali della Francesco Ciusa hanno la loro parte. E direi che è proprio il nome del grande artista titolare di quella officina ormai più che trentennale ad imporsi all’attenzione dei millequattrocento artieri giustinianei, in queste settimane, per la prossima ricorrenza giubilare: il settimo decennale della morte – passaggio all’Oriente Eterno – dell’autore del blocco “La madre dell’ucciso”.
L’Archivio storico generale ha assunto l’impegno di onorare degnamente, auspicabilmente in partnership con gli organi regionali del Grande Oriente d’Italia, la memoria del grande scultore nuorese: io penserei all’allestimento (assolutamente… francescano, per il fatto dopo che per il nome!) di una mostra capace di raccontare, in cento pannelli, i riguardi della stampa quotidiana sarda al genio ciusano, alla persona oltre che alla sua produzione d’arte, nonché ad un mediometraggio ancora sulla figura e la creatività di tanto autore. Il tutto accompagnato dalla illustrazione della sua cifra stilistica da parte di competenti storici dell’arte. Una iniziativa che, nata a Cagliari, dovrebbe avere autonome repliche ad Iglesias (o Carbonia) ed Oristano, Alghero e Sassari, Tempio (patria avita di Ciusa) e Olbia, Nuoro finalmente e Tortolì.
Nel tardo novembre 1988 le spoglie del grande scultore tornarono, per volontà dei nuoresi e in particolare del vescovo Melis e del clero diocesano, nel capoluogo barbaricino, patria nativa di Ciusa. Fu una cerimonia solenne che si concluse con la tumulazione di quei resti nella chiesa di Santu Caralu così legata alla biografia giovanile dell’artista.
Quel giorno il compianto amico Cesare Pirisi volle uscire con un numero speciale del suo La Nuova Città, recante su due pagine di ampio formato un mio articolo che, ricordando le vicende di vita di Francesco Ciusa, ne ricordava anche le incomprensioni subite, tanto più da parte di quel clero che ora reclamava ruolo nella celebrazione: la scomunica nel 1911 per la iniziazione massonica, la scomunica nel 1948 per la candidatura nelle liste social-comuniste al seggio senatoriale di Oristano. “Francesco Ciusa maestro di loggia” era il titolo.
Da Cagliari raggiungeva Nuoro anche questa testimonianza esprimente un franco sentimento: sentimento morale prima di ogni altra cosa.
L’anno innanzi, nel 1987 cioè, la loggia ad nomen aveva promosso la stampa, per la diffusione interna, di un libro titolato Quaderno di loggia la cui confezione mi fu affidata anch’essa ed in cui naturalmente richiamai l’esperienza della iniziazione massonica dell’artista in quel d’Oristano, la città che lo avrebbe visto, tre lustri dopo, felicemente intento alla direzione della scuola d’arte applicata voluta da Paolo Pili.
Mi è stato riferito che le ultime copie residuate nei magazzini siano state distribuite proprio nei giorni scorsi fra i liberi muratori della nuova generazione: dovranno, debbono conoscere ed a fondo, essi pure, i massoni dell’ultima leva, l’umanità e il talento dello scultore così come il quadro storico, tanto più isolano, in cui s’inserì la sua militanza segnalata dal grembiule, «simbolo del lavoro, primo dovere e massima consolazione dell’uomo», e dalla sciarpa scozzese.
Il grembiule massonico di un artista
E’ una questione di bruciante attualità condivisa dalla Massoneria con similari istituzioni umanistiche quella di come assicurare nei tempi attuali una corretta e coerente maturazione ed assimilazione dei fondamentali (solo all’apparenza datati): nel caso concreto è da dire che la Libera Muratoria, certamente sensibile ai segni dei tempi e dunque evolutiva come ogni altra realtà umana, non può evadere dalla sua natura di società “di tradizione”, che vive cioè con senso religioso il progresso storico e insieme resta fedele a principi e stili del suo impianto ideale e programmatico. Così negli approcci della dialettica civica, lontanissimo dal semplicismo dei piazzisti di turno anche oggi all’opera, tremendamente anche in Italia. La Massoneria nazionale deve conoscere e gustare il genio intellettuale e civile di Mazzini e Cavour e Garibaldi, di Mameli e Asproni, di Carducci e Collodi, Foscolo e De Amicis anche nel 2018. Naturalmente nella mediazione dei saggi e sempre meglio alla luce delle progressive esegesi storiche, ma ad ogni modo per ricavarne orientamenti etico-civili di inconsumata vitalità. Ecco qui l’espressione di una società cosiddetta “di tradizione”.
La questione è centrale e la voglio svolgere nuovamente con altre parole.
Ho collaborato tempo fa alla stesura di un libro sulle case massoniche d’Italia, in particolare elaborando le schede storiche di alcune delle maggiori sedi isolane. La cosa mi fa sensibile oggi a ripensare al Tempio ed ai Passi Perduti frequentati da Francesco Ciusa cento e più anni fa a Cagliari…
Meriterebbe, a questo punto, proprio una breve digressione sulle aule rituali e gli ambienti d’accompagno nella nostra Cagliari già dapprincipio e nel tempo successivo: a Palazzo Villamarina – poco distante dal duomo di Santa Maria – nella primissima stagione postunitaria, in via Gesù e Maria (dopo le prime “confabulazioni”, fra 1889 e 1890, presso l’Istituto Tecnico allogato nell’antico Fatebenefratelli del Portico Sant’Antonio) ed a palazzo Vivanet, finalmente, dal 1896; quindi a palazzo Fulgher – un edificio prestigioso di proprietà della Congregazione del SS. Sacramento nella Marina – dal 1907, celebrandosi il primo giorno due iniziazioni documentate poi in un opuscolo rintracciabile in qualche pubblica biblioteca cittadina, ed a luglio il centenario della nascita del generale Garibaldi…
A palazzo Fulgher, nella parte inferiore della centralissima via Barcellona – in un grande appartamento al primo piano, attrezzato anche degli svaghi borghesi tipici del tempo, scacchi compresi, sarebbero arrivati un giorno i dark, i questurini fascisti a tutto sequestrare e a chiudere le imposte per vent’anni; la luce, in contrasto invece, tredici anni prima, quando in quel certo giorno del 1912 da Oristano arrivò il giovane ma già affermato e ammirato artista nuorese. Lui scultore trovò allora anche qualche opera d’arte, qualche plastico che forse ebbe ragione di apprezzare, chissà: la copia del Giovanni Bovio in gesso pesante (opera del Fratello Pippo Boero, autore dell’originale in marmo bianco collocato nello square delle Reali), che i fascisti nel 1925 avrebbero prelevato come “prigioniero politico” – perché repubblicano e massone – e appunto relegato in un magazzino dei sotterranei municipali; trovò anche un busto di Giosuè Carducci (opera del Fratello Andrea Valli, impegnato altresì nella decorazione del nuovo palazzo comunale bacareddiano); trovò ad abundantiam un busto anche di Garibaldi raffigurato pure in una tela, al pari di Mazzini e Cavour e Vittorio Emanuele II – così come, a dire del quartetto, era nel non distante affaccio dei cornicioni di palazzo Picchi sito nel viale San Pietro (poi Trieste).
Immagini e labari ora della loggia ora del Capitolo Rosa+Croce e forse anche del Conclave dei Cavalieri Kadosh: tutto contribuiva a dar colore di risorgimento e d’età umbertina ad ambienti in cui gli artieri del Rito Scozzese Antico e Accettato – da cui la loggia intitolata a Sigismondo Arquer era regolamentata – dovevano tessere la stoffa delle idealità liberomuratorie, fra liberalismo politico ed umanitarismo sociale. Proprio allora, quando Ciusa frequentava le tornate della sua loggia cagliaritana, s’alzavano i pilastri del futuro dormitorio pubblico finanziato dai massoni della città (e da altri) e ceduto nel 1915 al Comune e da questo, in immediato, alla Croce Rossa per le insorte urgenze dei ricoveri bellici. Proprio allora, ad un passo da lì, nell’ex convento dei cappuccini adibito dal governo a ricovero di mendicità qualcuno dell’amministrazione affiggeva lapidi e collocava busti, il tutto in onore dei benefattori. Nel novero la loggia Vittoria, benemerita soccorritrice fin dal 1867, e alcuni artieri della Sigismondo Arquer: Nicolò Pugliese e Sophus Simmelkioer – entrambi monumentati –, presto anche Marcello Stocchino, un domani Giorgio Lai (iniziato nel 1918 e fatto Maestro anche lui in via Barcellona)…
Un luogo magico e certo dolente quello del viale degli Ospizi, fra il prossimo dormitorio/ospedale CRI e la chiesa di Sant’Antonio che era stata il rifugio spirituale di fra Ignazio da Laconi e, dai primi mesi del 1911, anche del giovane fra Nicola da Gesturi. L’umanitarismo dei laici o agnostici liberali e la spiritualità devota dei buoni cattolici si piegavano insieme sulle sofferenze degli ultimi, spingendo, ciascuno con i propri mezzi, per un riforma politica del sistema, per una legislazione sociale che emancipasse il bisogno dall’alea del buon cuore…
A Cagliari si metteva in campo, giusto allora, anche la formazione di una loggia tutta femminile, con la Satta e la Campagnolo e l’incoraggiamento del Saggissimo del Rito Scozzese, che si chiamava Oddo Casagrandi ed era docente di microbiologia all’università ed anche magnifico rettore, e s’era fatto volontario guidatore di tram nel quadro della mobilitazione civile a guerra appena esplosa fra le opposte trincee del settentrione italiano…
Tempi gravosi e di pena – già dai primi mesi di combattimento giunsero dal fronte le notizie della morte del giovanissimo Venerabile della Karales (Ottavio della Cà) e dell’Oratore della Sigismondo Arquer (Giovanni Romanelli) – e lo stesso Ciusa partecipò, dal fronte interno, alla temperie. A fine guerra fu lui l’artista incaricato dalla comunità veneta a Cagliari, presieduta dal Fratello Felice Pigozzo (farmacista capo all’Ospedale civile), per un decoro lapideo da affiggere su una parete della corte municipale al fine di ringraziare la Brigata Sassari dell’eroico valore mostrato nelle terre di confine nord-orientale della patria.
Certo ripensando a tutto questo e confrontandolo con quanto vien riferito oggi, chissà se a torto o a ragione, dell’assedio dislavaloriale alla fortezza massonica di Castello – con passaggi (fortunatamente minoritari e comunque mai commendevoli) di grillini e leghisti oltre che di pagani e mameliani di cartapesta (quelli che osano chiamarsi “Fratelli d’Italia” e sono fascisti deodorati) – vien quasi da rimpiangere il tempo passato, perché comunque, nonostante il nuvolone nero della guerra in approssimazione, s’avvertivano gli slanci d’una storia evolutiva e la Massoneria non sbagliava nello scegliere il campo in cui collocarsi, contro l’autocrazia asburgica e per la democrazia liberale di Francia e Inghilterra.
Domande per l’oggi
Certo la storia è un permanente chiaroscuro e ogni manicheismo appare idiota. Ciò non di meno, in quanto Fratellanza umanistica, sì trasversale in quanto alle professioni partitiche ma non mai dubbiosa in quanto ai vincoli di patria e democrazia – il maggior conio mazziniano nella storia d’Italia –, la Libera Muratoria vissuta da Francesco Ciusa respirava la passione della libertà e del tricolore: quello stesso che il giovane nuorese aveva salvato, come fosse il simulacro del migliore dei santi, da un tumulto negli anni in cui studiava a Firenze.
Tanto più in tempi di avvilente decozione degli ideali alti che sempre sono chiamati a sostenere, senza dottrinarismi ma con passione morale, i grandi progetti, la Libera Muratoria, anche quella sarda e cagliaritana, potrebbe o dovrebbe elevarsi richiamando nel suo oggi quel tanto che la sostenne un tempo, avvertendo l’integra attualità dei suoi costituenti – quelli risorgimentali e quelli dell’antifascismo democratico – e, per contro, il nulla delle scatole vuote nelle quali diversi (molti?) dei suoi s’intrappolano ora per accidia ora per indulgenza al tatticismo. I nomi nella vita pubblica attuale ci sono tutti: grillini e leghisti, forzisti e destri, sardisti in riciclaggio confuso e ignorante, tanta parte dei cosiddetti democratici.
Mi fermo ad una sola stazione, quella sardista. Tutta la storia dell’autonomismo, quello amato da Francesco Ciusa, fu già dalle origini prossima alle idealità liberomuratorie: si pensi soltanto a Efisio Mameli Cubeddu, si pensi a Bartolomeo Sotgiu e – anche per la storia successiva, dopo la testimonianza antifascista – ad Annibale Rovasio, si pensi a Pietro Mastino nientemeno, ai bosani di Melkiorre Melis, ad intellettuali come Ovidio Addis e Quintino Fernando, Giuseppe Marongiu mitico preside e Fernando Pilia mitico professore omnibus, alle anime migliori di Carbonia come Efisio Costa e Giorgio Carta (tempi di Carbosarda!), a dirigenti come Emilio Fadda ed a sindaci di capoluogo come Luigi Satta e Davide Cova – perseguitato dal regime già dai tempi del manganello – ed ai riattivatori della sassarese Gio.Maria Angioy, pressoché tutti sardisti di stretta e rivendicata religione italiana e mazziniana!
(Potrebbe mai un massone sardista – se non soltanto di tessera – sostituire oggi Mazzini con Salvini, dopo le miserie della bandiera donata a Berlusconi e la pessima segreteria padronale Sanna? E allo stesso modo, potrebbe mai un massone forzista sostituire Cavour o Giolitti con il grande evasore e dell’Utri e Previti e qualsiasi altro della scempia nomenklatura? E’ nervo scoperto questo delle compatibilità fra le militanze correnti e le scuole di pensiero che hanno costruito l’Italia e l’Europa lungo due secoli e, seppure in forme aggiornate, legittime ancora nel presente contro ogni deriva. Per certo, una società “di tradizione” non può mai dispensarsi dall’esigere da se stessa rigore assoluto di coerenza nella “catena d’unione”: per essa l’oggi, indubbiamente faticoso e complesso, deve potersi specchiare con piena dignità in un ieri non meno faticoso e complesso, certamente non immacolato ma comunque nobilmente creditore. Proprio la trasversalità e l’ecumenismo principio costitutivo della Libera Muratoria, lungi dall’essere un passepartout, dovrebbero impegnare i “diversi” a riconoscersi nei fondamentali che sono sempre di contenuto e di forma. Non è accademia ed è urgenza sulla quale si misura una classe magistrale della Libera Muratoria che voglia essere degna di chi – gran maestro – fu costretto al confino o all’esilio antifascista in Francia, da Torrigiani a Chiesa, da Meoni e Leti ad Alessandro Tedeschi tanto legato anche alla Sardegna!…).
I nomi dei titolari delle logge isolane – mi riferisco ai sardi – dovrebbero poter dire molto, moltissimo anzi, orientando nell’oggi l’impegno, singolare o collettivo, degli effettivi: Gio.Maria Angioy, Goffredo Mameli, Giorgio Asproni, Ovidio Addis, Bruno Mura, Alberto Silicani, appunto Francesco Ciusa…
Ho sopra accennato al libro che la nuova loggia cagliaritana mi incaricò di confezionare per salutare la nascita dell’ensemble e specialmente per onorare il suo titolare, la personalità dell’artista caro al sentimento, allora almeno, di tutti.
Eccone qui appresso, come anticipazione di quel che potrò fare per celebrare il prossimo 70°, il mio testo.
Nuoro, Ballero, Satta
1907-1987: ottant’anni esatti – anche i giorni sono questi di primavera inoltrata – dallo straordinario successo di Francesco Ciusa, allora appena ventiquattrenne, a Venezia, alla Biennale. La sua “Madre dell’ucciso” s’era imposta come un’opera mirabile, ineguagliabile, all’attenzione di critica e di pubblico, e quell’entusiastica, incantata approvazione aveva superato e smentito le riserve di amici fidati come Sebastiano Satta e Antonio Ballero, che avevano creduto incapaci tutti quanti, in primis la stessa Commissione Internazionale di accettazione alla esposizione veneziana, di comprendere quel mix di cuore e di tecnica, esito ad un tempo di genio artistico e di un puro sentire.
Quelle di Satta e di Ballero erano state perplessità che avevano indotto «il giovane artista ad abbandonare per più d’un mese la figura modellata ricoperta di cenci bagnati», come lo stesso Ciusa avrebbe rivelato nei suoi appunti autobiografici assai più tardi. Un limbo nello studio-pagliaio ai confini di Santu Predu, nella Nuoro della Deledda, dei Satta, dei Dessanay e dove ancora viva era la memoria dei poeti dell’ “Atene” democratica e repubblicana come il Rubeddu o il Murru, e di quelli che dalla lingua neolatina succhiata nelle case, da bambini, avevano saputo trarre suoni ed umori per costruire, in rima, monumenti in lode del vino non meno che della libertà sognata; nella Nuoro dove il culto d’un Asproni muoveva le generose e minoritarie energie mazziniane e cavallottiane e suscitava la sempre rinnovata fiducia del mandato parlamentare a un Giuseppe Pinna, prossima vittima d’un agguato per la morte; la Nuoro della 7.051 anime di cui ha testimoniato, tutte risuscitandole dal loro nulla, Salvatore Satta; la Nuoro di pittori come Giacinto Satta ed Antonino Pirari e di poeti come Francesco Cucca, di intellettuali inquieti e profeti come Attilio Deffenu, di giuristi come Gian Pietro Chironi e di grandi penalisti – i maggiori dell’isola – nella cui oratoria riecheggiavano tutte le esperienze secolari degli improvvisatori; la Nuoro “gallica” dei quartieri-stato; la Nuoro riclassificata – a seconda del quantum d’armenti, d’acri, d’assassinatj, di diplomi – in ricchi e poveri e moderni, in ceti pastorali, agricoli e borghesi, distribuiti fra slarghi e feritoie a San Pietro, a Seuna o tutt’attorno al nuovo Corso, la via Majore, la strada obbligata per Santa Maria della Neve, per la Solitudine, per l’Orthobene col suo gigantesco bronzeo patrono: il Redentore. Nuoro violenta e gretta, Nuoro grande e sofferente, Nuoro lacerata, Nuoro degli anni di trapasso epocale.
Era giusto la metà d’aprile del 1907 quando il quotidiano liberale di Cagliari ospitò una corrispondenza di Nino de Nugor, alias Antonio Ballero. Titolo: “La vittoria dello scultore nuorese Francesco Ciusa all’Esposizione di Venezia”. Una testimonianza che merita d’esser richiamata per capire forse tutto quanto, prima ancora di cominciare, di Nuoro e del suo artista.
«Ricordo ancora – scriveva Ballero – il sorriso di disprezzo col quale, cinque anni or sono, alcuni consiglieri, proprietari di “tancas e baccas”, ma zottici e ignoranti, avevano accolto la lettera di una timida domanda del giovinetto Francesco Ciusa, tendente ad ottenere dal Comune un sussidio che gli permettesse di studiare scultura in un istituto di Belle Arti del continente! Che cosa avrebbe guadagnato Nuoro sussidiando un artista? Uno spostato di più e qualche migliaio di lire di meno! Così pensavano parecchi dei nostri padri coscritti!
«Ma la parola calda e persuasiva di molti altri, ché dell’arte avevano un altissimo concetto, valse a far ricredere i più riottosi, i quali finirono per riconoscere le bellezze, piene di promesse, di un bozzetto di creta presentato dal Ciusa, e raffigurante uno dei tanti gavroche che vivono, disgraziatamente, abbandonati nelle vie della nostra città, e il sussidio fu votato a gran maggioranza.
«Fu quello un giorno di gran festa per il Ciusa! Gli pareva di aver conquistato il mondo, ottenendo dal Comune una borsa di trecento lire all’anno, bastevole appena per fargli soffrire dignitosamente la fame in una gran città! E furono tre anni di sofferenze quelli che egli passò a Firenze, ove pur digiunando compì in soli tre anni tutto il corso che è di cinque, premiato con una menzione onorevole e una medaglia di merito.
«Tornato a Nuoro con un gran sogno luminoso di gloria negli occhi, studiò giorno e notte, torturandosi nell’affannosa ricerca del soggetto d’una statua che potesse renderlo noto nel difficile campo dell’arte. Quante statue, quanti gruppi ideati e plasmati furono successivamente distrutti dalle sue mani nel solitario studiolo [ ... ]. Ma finalmente riuscì ad afferrare e a dar corpo all’idea. Dopo lunghi mesi di lavoro tormentoso diede l’ultimo tocco alla sua statua: “La madre dell’ucciso”.
«Ho ancora viva davanti agli occhi la figura dolorosa di quella vecchia sciagurata, accoccolata dinanzi al focolare, vinta, distrutta, quasi scheletrica, in una sola notte di pianto e d’angoscia. Ella ora non piange più; alle lagrime è subentrato quel dolore che solo può intendere una povera madre alla quale la mano d’un assassino tolse il figliolo, quel dolore che non vuole e non può avere conforto.
«Il Ciusa ha fatto un’opera mirabile superando tutte le enormi difficoltà che si opponevano alla sua riuscita ed ha vinto [...].
«Tutta la cittadinanza nuorese si è congratulata col giovane scultore che ha esordito trionfalmente nella luminosa carriera dell’arte con un grido che risuona tanto dolce al suo orecchio e specialmente al suo autore: Vittoria!».
Con quei baffi e il pizzetto, e in testa un basco largo e scuro, è poi la farfalla al collo, magro, gli occhi vivaci, quasi da veggente (uno sguardo che avrebbe conservato anche da vecchio), Francesco Ciusa si presentava così alla scena isolana e nazionale, giovanissimo, e giovanissimo veniva accolto già come un maestro. «Ero come ubriaco senza bere un goccio di vino», avrebbe confessato. Il successo lo stordì, ma solo per breve tempo, non lo cambiò. Fedele alla terra e alla gente da cui veniva, avrebbe illustrato con la sua arte i temi dell’umanità sarda semplice, che conosceva bene, un’umanità con una religione: il lavoro, e una regola: la famiglia.
Berlinguer, Ojetti e Marchi
In quel suo primo e straordinario gesso aveva scaricato i ricordi dell’infanzia, quelle impressioni provate ascoltando i racconti dei vecchi ed osservando dal vero gli uccisi nelle campagne della Barbagia, perché disertava la scuola per arrivare sul posto della tragedia prima dei carabinieri, come ha scritto Remo Branca. Nella sua scultura c’era anche il riflesso di quel cupo mutismo materno «davanti al focolare spento», tante volte religiosamente incontrato da bambino e da ragazzo. Da quella compostezza veniva la sua arte senza risa ma pure senza stemperamenti in lacrime, un’arte «tetra e solenne, vibrante di passione contenuta», come nel ’14, in un articolo pubblicato su Sardegna, la rivista di Attilio Deffenu, il nostro Gobetti socialista, aveva commentato Mario Berlinguer.
Era stato Ugo Ojetti – il leader dei critici d’arte del tempo – a scrivere sul Corriere della Sera parole impegnative per quel gesso «così profondamente osservato, reso con tanta coscienza, costruito con tanta scienza».
In uno scritto apparso nel famoso numero speciale dedicato alla Sardegna dal Ponte di Calamandrei, nel ’51, anche Raffaele Marchi tornò ad apparentare, come avevano fatto molti critici prima, quella madre ciusana a quell’altra “mater” nuragica, «modello e simbolo» di una storia che per la Sardegna è stata per millenni, per questo o quell’aspetto, sempre uguale. Allora – osservò il Marchi – «le stragi dovevano interrompere spesso il ritmo delle attività, pacifiche, doveva succedere spesso di fermarsi davanti a una madre che piangeva il figlio ucciso da un nemico o da un potente capo rapinatore, e che in quel momento d’immobilità, o di silenzio diventava attrice e protagonista dell’umana vicenda: così la vide l’ignoto scultore nuragico…».
E anche ora, anni d’esordio del secolo nuovo, quanti drammi sociali e privati! «Nel nord, e specialmente nei paesi della Barbagia, imperversava il crudele fenomeno delle lotte sanguinose tra famiglie, determinate da cause che in un modo o nell’altro si riducevano alla difesa o all’acquisto violento del diritto di proprietà… Nel sud invece cominciavano a manifestarsi e ad articolarsi le lotte sociali dei contadini e degli operai; nelle rivolte di Cagliari e di Buggerru altre madri piansero figli uccisi. La tragedia era ancora dì tutto un popolo, e l’immagine altolocata che la esemplificava fu ancora la figura dì una madre luttuosa». Ecco: «La realtà, che suggerì a Francesco Ciusa il soggetto della madre non era sostanzialmente diverso da quello che aveva ispirato l’arcaico artista nuragico… Le due “madri” sembrano chiuse in un’identica atmosfera lirica; e sembra che piangano allo stesso modo, composte e immobilizzate in un dolore interamente spiegato nel silenzio dell’animo, senza possibilità di conforto e di remissione al di là, dei termini umani…».
Francesco Ciusa o dell’amicizia: testimone d’un valore alto, forse il più alto di cui l’uomo possa dirsi capace, impegnando il meglio delle sue virtù. Franzisku e Bustianu, Bustianu Satta: un’amicizia intessuta di confidenze, di esortazioni, di consigli, di sfoghi, di domande, la loro.
Negli anni dell’Accademia fiorentina dal suo amico poeta gli era giunto un messaggio che era come un’anticipazione del successivo: «Tira innanzi sereno e sii forte e degno della vita e dell’arte cui ti sei votato. Pensa che il lavoro, che l’ideale possono soli redimere ed elevare il cuore e sii buono! Non pascere la mente di sogni vani e di speranze fallaci.., lavora, lavora, lavora ! … Serba nel cuore tuo un po’ di quella selvaggeria della Barbagia nostra e ti sorregga sempre il pensiero di chi ti vuol bene». Lettera per la “notte”: 1903.
Come nella liturgia delle Ore
La notte. Il Natale di Lazzaro fu il primo tempo della trilogia – quasi una parafrasi laica della cristiana liturgia delle ore, ma echeggiante pure motivi antichi, pagani, misterici forse – in lode di Francesco Ciusa, parte centrale dei Canti barbaricini.
«Vedi è Natale: scende dai pertugi / Del soffitto la luna e imperla un velo / Sull’insonne occhio tuo. Negli stambugi, / Se c’è la luna, vi si addoppia il gelo. / Odi? rombano, cantan con anelo / Empito le campane, e tu trangugi / Fiele, ed i tuoi pensier, neri segugi / Arrandellati, abbaian contro il cielo [...] »: così comincia quel Natale di Lazzaro, allegoria delle mille incomprensioni che dal chiuso ambiente nuorese eran venute all’amico scultore non ancora famoso, dopo che alla Deledda…
E dopo la notte, il “mattino”: 1904. Alla Fonte, i primi successi: «Tu devi vincere!», scriverà il poeta al suo giovane amico. «O Francesco, la prima creatura / Che ti sorrise dalla sanguinosa / Nostra terra, sfiorì come una rosa / Selvaggia in un mio canto di sventura. / Or la rivedo, schiusa dalla pura / Tua mano giovanil, con rugiadosa / Fronte di gloria, riguardar secura / Oltre il sogno, alla sua vita affannosa…», eccetera.
Ancora: dopo la notte ed il mattino, ecco finalmente il “meriggio”: 1907. La madre dell’ucciso: «Mio piccolo grande fratello, ricevo in questo momento, ore dodici di domenica, la tua lettera… Or sì puoi desiderare e comandare dall’altura luminosa ove sei!… Ti attendiamo con affettuoso entusiasmo. Torna alle divine montagne!!!», e scrisse: «Madre, nel grido della turba, il carro / Trainò l’ucciso figlio tuo dal monte; / E troppo lenti erano i, gravi bovi / A portartelo al tuo solo dolore. / Or te lo senti ripassar sul core / Il sanguinoso carro [ ...].
«O Francesco, o fratello! / Da quali nostri cieli taciturni, / Errando per pianure d’oleastri, / Ti mosse incontro questa forma viva?] I tuoi sogni lontani eran come astri / Accesi sopra solitaria riva. / E a te venia dall’ombra antelucana / La parola profonda / Di questa terra antica: / E ascoltasti l’insonne / Vento seminatore / Nella tanca lontana; / E adorasti il silenzio /: Del ciel meridiano [...].
«Se l’aurora arderà sui tuoi graniti / Tu lo dovrai, Sardegna, ai nuovi figli. / A questo: a quanti cuori / Vegliano nella tua ombra, aspettando! / O fratello, e tu primo alla vittoria, / Da’ il grido dai vermigli / Pianori. Agita il palio… / O rosso cavallo, / O cavallo di gloria, hutalabì!».
Eppure, s’è detto, non ci aveva creduto subito, il Satta, alla “Madre dell’ucciso”. Non che disistimasse l’opera, anzi; era all’accoglienza da parte degli altri che non credeva; gli era sembrato un azzardo, un’avventura, troppo nuovo quel gesso rispetto ai canoni neoclassici, alla corrente nudista, allora dominanti nel gusto artistico. Troppo nuovo quel modello eppure così antico, remoto, parente di una certa produzione nuragica, un elemento in più, forse, per determinarne l’esclusione. Per fortuna c’era stata Peppina Deledda, la sorella di Grazia, a capire d’istinto più di tutti, e Venezia era venuta di necessità con tutto il successo possibile, nazionale e internazionale.
«O Francesco… da quali nostri cieli.., ti mosse incontro questa forma viva?»: Il Satta, da poeta e prima ancora da amico, a tale domanda già avrebbe saputo rispondere nel suo intimo. Perché spesso si parla di cosa sia l’universalità dell’arte, di come essa s’esprima nel colloquio fecondo con le culture più diverse; e Francesco Ciusa, forse perché ancora uomo in boccio, più vicino all’antimondo (o antemondo) delle intenzioni che non alla storia delle divisioni e delle lotte, era stato capace di impadronirsi di quel linguaggio universale, l’aveva quasi incarnato. Il Satta non poteva non saperlo. La sensibilità di un amico, di un amico vero, queste cose le avverte, le respira nell’aria: non c’è bisogno di discuterle né tanto meno di provarle, di dimostrarle.
Sodalizio esistenziale, comunione di valori, uno spartito il loro, come quello di ogni altra amicizia profonda, davvero per la vita, in cui le note giocano tutti i ruoli della vita, ora sereni o allegri o scherzosi, ora dolenti e drammatici. E dunque perché accanto alla severità dei temi poetici come quelli della madre dell’ucciso non potevano stare i ritmi d’un epigramma come questo, dono del Satta al suo giovane amico ancora ubriaco di Venezia: «Io sono Francesco, il padre della madre / Dell’ucciso, e sono l’avolo del figlio… / Così a vent’anni, puro come un giglio / Divento nonno prima d’esser padre… »?
Che amicizia straordinaria quella fra Bustianu e Franzisku! Non è forse amicizia vera e profonda quella lungo cui possono scorrere confessioni intime come le seguenti? «Sono addolorato perché qui in casa non vi è che dolore, ed ho disimparato anche il sorriso. Sto qui, nella mia terra, anzi nella mia lustra, e mi nutro di me stesso, del mio cuore… Oh fratello! Pure fra questo affanno mi sento tranquillo, se non felice: poiché la voce della mia coscienza tace al fin, ed io stesso a me stesso, nei colloqui intimi col mio spirito sempre vigile, non ho nulla da rimproverarmi. Ormai per me è deciso, e vedo a me d’innanzi la sola via che mi sono schiuso seguendo la traccia che mi veniva segnata dalla dea Bontà! Come è felice ora quella mia amata creatura! – E la sua gioia, e il non veder più nel suo volto quell’assiduo dolore, quel rimprovero muto,- quella desolazione quasi senza speranza che la torturarono per me così a lungo!
«Ciò mi dà contentezza e gaudii indicibili… Io taccio, penso, fumo, ma non invidio più le alberelle e non bestemmio più e mi sento più buono».
Il poeta e l’artista, gli annunziatori d’una civiltà, alta e spirituale, ma non astratta, non legata o condizionata a miti inafferrabili dall’umanità… dell’uomo “alfa e omega” della propria storia.
Francesco Ciusa e Nuoro, Francesco Ciusa e il trionfo veneziano, Francesco Ciusa amico. Ora Francesco Ciusa filtrato dalla memoria dei familiari, del figlio maggiore, suo testimone anche in Massoneria.
«Mio padre scolpiva quando ne sentiva la necessità interiore, mai su ordinazione. Regalava le sue opere solo che gli si facesse capire di averne inteso l’intima bellezza. Quando lavorava si concentrava tanto sul soggetto che ogni minimo rumore nello studio lo faceva sussultare, lo scuoteva tutto fino a spaventarsi. Non mangiava, non dormiva sino a che l’opera non era compiuta e, una volta realizzata, la lasciava lì, senza mai più ritoccarla. Di intensa, affascinante comunicativa, sapeva trasmettere agli amici la sua prorompente vitalità d’artista. A tutti, anche ai bambini, alla gente del popolo…». Sono parole di Nino Ciusa, che del genitore aveva conservato fino alla morte una devozione adulta eppure “fanciullesca”.
Ne ricordava la sobrietà, la semplicità di vita, la povertà materiale, la generosità. Si potrebbe dire: un figlio che sia stato tenuto per mano dal padre, che da chi l’ha generato abbia saputo trarre anche tutti gli impulsi di quella vita spirituale che si sfoga nei comportamenti del quotidiano, nella parola e nei gesti, nello sguardo, nel pensiero e nei silenzi, un figlio così rivela naturaliter i segni della paternità goduta, ne esprime la cifra che fra le infinite possibilità non ha né può avere uguali.
E Nino – s’è detto – testimoniava il padre in loggia, perché di lui aveva deciso di proseguire anche il tracciato massonico.
Nella loggia di via Barcellona
Aveva solo ventinove anni Francesco Ciusa quando entrò per la prima volta in un tempio libero-muratorio. Avvenne a Oristano, presso la loggia “Libertà e Lavoro”. Ed era già un nome lui, e che nome! Dopo “la Madre” aveva presentato alle mostre e al grande pubblico, “il Pane”, “la Filatrice”, “il Nomade”, “la Bontà”…
Nell’autunno del 1912, poi – il 10 ottobre precisamente – s’era affiliato alla cagliaritana loggia “Sigismondo Arquer”. L’Italia – giusto in quei giorni – poteva dire di essere finalmente uscita dall’avventura libica, di aver vinto la sua sanguinosa scommessa africana. Il trattato di Losanna, chissà, poteva anche compensare molti lutti, infiniti sacrifici… Una stagione si chiudeva nella storia civile e politica del Paese, un’altra albeggiava non meno drammatica.
Più volte nel ’12 la “Sigismondo Arquer” aveva aperto il suo varco d’occidente per accogliere profani “uomini liberi e di buoni costumi” e fratelli che, per ragioni soprattutto professionali, avevano lasciato l’oriente d’origine trasferendosi a Cagliari. Nel ’13 – maggio – l’artista era poi divenuto compagno “d’arte” e l’anno successivo era stato promosso maestro.
Francesco Ciusa massone, e massone giovane: una storia tutta da scrivere all’interno del suo vissuto privato e di quello collettivo di loggia, nel quadro culturale del tempo, dei referenti morali e civili del tempo.
E Francesco Ciusa “cagliaritano”, Francesco Ciusa rotto dal dolore per la città squassata dall’acciaio piovuto dal cielo, tra febbraio e maggio 1943, Francesco Ciusa visitato dal santo cagliaritano per eccellenza, fra Nicola, nella sua casa, poco prima di morire. Un colloquio forse solo di sguardi, ispirato e beato. Nel nome alto dell’Uomo che scopre dentro di sé una luce che viene dall’eternità ed è per sempre, e finalmente disvela la relazione misteriosa fra il particolare “alfa e omega” e le ragioni d’un macrocosmo che riassume tutte le storie vissute. Francesco Ciusa cagliaritano, e massone cagliaritano: un altro, ulteriore campo di ricerca per chi ha inteso onorarlo a lui intitolando una loggia.